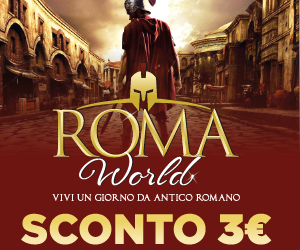Quella del cardinale decano del Sacro Collegio, Giovanni Battista Re, alle solenni esequie di Papa Francesco non è stata certo un’omelia “sobria”. È andata invece dritta al cuore dei punti chiave del pontificato di Bergoglio, che hanno anche sconvolto tradizioni e sconcertato i “potenti”, a cominciare dalla scelta del suo nome pontificale, Francesco, che nessun altro prima di lui aveva avuto il “coraggio” di scegliere, per indicare quello che era per lui, sulla scia dell’esempio del santo di Assisi, il fronte su cui schierare la Chiesa: povertà, emarginazione, periferie.
La “sobrietà”, che dal governo nel nostro paese è stata evocata in funzione delle celebrazioni per il 25 aprile, a cui ha replicato il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, specificando che coloro che festeggiano la Liberazione dal nazifascismo non sono «certo quelli del Papeete», nella omelia del cardinale Re non c’è stata: è stata una lunga e articolata dichiarazione dei principi che hanno segnato il pontificato di Francesco, senza infingimenti, formalità, omissioni sui punti di rottura con i “potenti”, interni ed esterni alla Chiesa. E sulle innovazioni introdotte: non a caso l’allora cardinale Bergoglio aveva indicato come suo punto di riferimento Paolo VI, un Papa certo non “scenografico”, ma di grande sostanza per innovazioni e riforme nel cammino spirituale e umano del mondo cattolico.
Francesco è stato il Papa degli ultimi, che ha definito la guerra una sconfitta per tutti, «perché dopo lascia il mondo peggiore rispetto a come era prima»; il Papa che ha esortato instancabilmente i potenti del mondo a cercare la pace attraverso tutte quelle strade che possano portare «a una soluzione condivisa»; il Papa che si è rivolto «agli uomini e alle donne», cosa quest’ultima non scontata come riferimento di genere in una celebrazione solenne da parte del cardinale decano: tutto questo è stato Francesco, come ha ricordato nella sua omelia Re.
Una lunga e appassionato omelia, quella di Re, che ha ripercorso tutti i passi salienti del pontificato appena concluso, a cominciare dal primo dei tanti viaggi pastorali, che come ha raccontato il cardinale decano è stato a Lampedusa, l’isola che, ha ricordato, è diventata la destinazione di tanti disperati in fuga da fame, guerre e violenze, molti dei quali sono stati inghiottiti dalle acque del Mediterraneo in quel viaggio della speranza: un riferimento che richiama fortemente alle nostre coscienze, ancor più se si è credenti, ciò che è successo dopo che si è voluto mettere fine all’operazione “Mare nostrum”. Poi ancora un viaggio che ha segnato un’epoca: quello in Oceania, «la periferia delle periferie».
Francesco, ha ricordato Re, «ha mantenuto il suo carattere» di quando era il pastore Bergoglio, come frutto della sua esperienza spirituale nella Compagnia di Gesù e quella maturata sulle strade di Buenos Aires e nelle periferie del mondo, con quello spirito missionario che l’ha accompagnato fino all’ultimo.
E infine quell’ultimo commovente saluto, «che resterà per sempre nelle nostre menti e nei nostri cuori», ha detto Re, quando domenica scorsa, in occasione della Pasqua, si è affacciato per un saluto ai fedeli, nonostante le precarie condizioni di salute. Ma non gli è bastato. Nonostante lo sforzo, ha voluto muoversi incontro alla gente con la “papamobile” scoperta in quello che rimarrà per sempre il suo ultimo abbraccio.
Un abbraccio, come ha ricordato il cardinale decano, con cui ha stretto insieme credenti e non credenti, cristiani e fedeli di altre confessioni: andare incontro al mondo e coltivare il dialogo interreligioso è stato un altro punto cardine, come ha ricordato Re, che ha ormai già consegnato Francesco alla storia. E non sarà, comunque vada, un pontificato che non lascerà traccia nella Chiesa moderna.
Con buona pace di coloro che, intimamente, nel salutare per l’ultima volta il primo Papa venuto dal Sudamerica, terra tormentata e ricca di spiritualità, si aspettano che il prossimo Conclave scelga un Papa meno “ingombrante” per i potenti del mondo. Cioè molto più “sobrio” di Francesco.